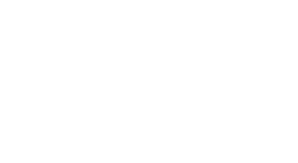Attualità
/
17/07/2025
Ufficio del futuro: spazi ibridi tra benessere e relazioni
L’evoluzione degli spazi del lavoro tra ibridazione, benessere e connessione
L’ufficio non è morto: si è evoluto. Gli spazi di lavoro post-pandemia diventano hub relazionali in grado di stimolare innovazione, benessere e collaborazione. Con il lavoro ibrido sempre più diffuso, progettare ambienti flessibili, multifunzionali e inclusivi è la nuova sfida. Dai coworking agli asili aziendali, il futuro del lavoro passa dall’architettura.
Possiamo affermare con convinzione che la preannunciata “morte dell’ufficio” che sembrava costellare gli articoli sul futuro degli spazi del lavoro durante la pandemia, non si è verificata affatto. Anzi, l’edificio per uffici – si fa riferimento nel testo in particolare al settore terziario e alla società dei servizi –, sebbene ridotto in alcuni casi nelle dimensioni e con una nuova organizzazione interna, resta tra i luoghi principali entro cui svolgere la prestazione lavorativa come ambiente in cui condividere idee, competenze e relazioni, favorendo quelle dinamiche di confronto informale e collaborazione che risultano fondamentali per l’innovazione, la crescita professionale e il benessere. La pandemia ha però sancito la fine di un modello organizzativo basato su confini spaziali ben definiti e regolato da una temporalità sincronica1.
Queste due condizioni hanno delle ricadute dirette anche sul progetto degli spazi del lavoro che di fronte all’imperativo del “work is where you are” si sono dovuti confrontare con l’impatto generato dall’applicazione dello smart working (Legge n.81 2017), oggi presente soprattutto nella modalità di lavoro ibrido, e con le nuove esigenze di lavoratori e lavoratrici.

Axel Springer Campus a Berlino, studio OMA.
Lavoro agile: i dati chiave di una tendenza in crescita
Gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano nell’ottobre 2024 descrivono per il territorio nazionale uno scenario stabile rispetto all’anno precedente con un aumento nelle grandi imprese con circa 2 milioni di lavoratori (+1,6% sul 2023), un calo nelle PMI, da 570.000 nel 2023 a 520.000 nel 2024, e una stabilità nelle microimprese e nella Pubblica Amministrazione. La media dei giorni di lavoro da remoto si attesta sui nove al mese. L’Osservatorio ha inoltre rilevato come questa modalità lavorativa sia sempre più richiesta da lavoratori e lavoratrici mostrando come una eventuale eliminazione comporterebbe per il 27% la possibilità di cambiare lavoro e il 46% proverebbe a far cambiare idea al proprio datore di lavoro. È opportuno inoltre ricordare che il lavoro agile è “una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro” (voce Smart Working, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) per superare anche il divario di genere. Tuttavia, l’Italia resta uno dei paesi in Europa con minore utilizzo di questa fattispecie lavorativa 43,5%, al contrario di Olanda, Irlanda, Finlandia e Germania con percentuali intorno al 70% (Eurostat). Il futuro del lavoro sarà sempre più ibrido: se la tecnologia rafforza il senso di appartenenza di una comunità anche a distanza, la presenza fisica e lo scambio, sia intellettuale sia corporeo, restano elementi imprescindibili.

CRA-Carlo Ratti Associati, Open Innovation Center del Gruppo Sella, Torino.
Nuovi modelli di ufficio: casi studio nazionali e internazionali
Il nuovo paesaggio lavorativo si configura, quindi, come una rete di luoghi in cui si trovano un hub centrale (sede principale dell’azienda) e la casa o uno “spazio terzo”, come i coworking o sedi locali, in cui lavorare nei giorni di smart working2. Questa nuova geografia comporta la necessità di ripensare l’edificio per uffici come hub relazionale, non solo in senso spaziale ma anche considerando il benessere di lavoratori e lavoratrici. Alcuni casi noti sia a livello internazionale sia nazionale mostrano riflessioni comuni riguardo alla centralità degli spazi condivisi dove poter aumentare i momenti di scambio che tanto sono mancati durante le fasi di chiusura forzata della pandemia. Il progetto Axel Springer Campus dello studio OMA (2013-2020, Berlino) si costruisce attorno a un grande open space, un atrio triangolare su cui si affacciano dieci piani sfalsati e terrazzati con postazioni differenti in relazione al tipo di lavoro: uffici singoli, coworking, sale riunioni, zone relax. Al piano terra sono inoltre presenti ristoranti, spazi per eventi e mostre in continuità con lo spazio urbano esterno. La tipologia a terrazze si ritrova anche nella proposta che Carlo Ratti disegna per l’Open Innovation Center di Sella (2025, Torino) il cui progetto si definisce attorno a quella che l’architetto chiama una “piazza” proprio come quelle che caratterizzano i nostri spazi urbani. Una serie di terrazze attrezzate si affacciano sul vuoto centrale che ospita una caffetteria pensata come interfaccia con l’ecosistema locale, l’agorà per eventi e workshop. Internamente sono presenti diverse tipologie di ambienti per il lavoro: hot-desk ovvero postazioni singole non assegnate e prenotabili via app, phone booth per call, project room ovvero sale modulabili con arredi su rotelle e pareti perimetrali write-able e, infine, il coworking Sellalab con scrivanie per start-up anche esterne. Questa soluzione spaziale era già stata sperimentata alla fine degli anni Sessanta dall’architetto olandese Herman Hertzberger per gli uffici Centraal Beheer (Apeldoorn 1968-72) il quale aveva considerato l’aspetto relazionale al centro del progetto con lo svuotamento dell’angolo dei singoli cubi per creare punti di incontro. Dal punto di vista dell’arredo sembra prevalere la scelta di flessibilità e mobilità. Grandi aziende come Vitra (Club Office 2021; Comma 2022), Herman Miller (Clubhouse 2021) e Ikea stanno promuovendo sistemi di arredo su rotelle che riprendono la tipologia club individuata molti anni prima dall’office planner Francis Duffy (1997).
Nel lavoro ibrido l'ufficio resta spazio d'incontro: flessibilità, multifunzionalità e benessere rafforzano innovazione e comunità

CRA-Carlo Ratti Associati, Open Innovation Center del Gruppo Sella, Torino.
Benessere nei luoghi di lavoro: dagli asili aziendali alle palestre
Infine, un’ultima tendenza è quella di considerare l’introduzione di attività legate alla cura e al benessere dei lavoratori/lavoratrici anche con spazi legati alla genitorialità, aggiungendo nuovi padiglioni che ospitano asili-nido. Si citano a tal proposito CARIbimbi asilo nido di Cariparma progettato da ZPZ Partners (2011) che integra criteri di sostenibilità e innovazione pedagogica e l’edificio Adidas Kita di Agps architecture (Herzogenaurach, 2011-2014) che ospita al suo interno un asilo nido e una palestra per i dipendenti. Inserire questo tipo di attività nella sede aziendale, oltre a generare valore per i dipendenti, innesca una relazione virtuosa con il territorio facendo dell’impresa un attore attivo nel welfare locale. Nel lavoro ibrido l’ufficio resta spazio d’incontro: flessibilità, multifunzionalità e benessere rafforzano ancora innovazione e comunità, con vantaggi per persone, imprese, territori e cultura più diffusa.
*1Bassanelli, M., Forino, I. (2022). “Lavoro immateriale e pandemia. Dalla worksphere all’Ho-Wo in-between”. Territorio, n. 97, pp. 17-26.
2Bassanelli M., Ingrao A., Satta C., Spazi per il lavoro a distanza e per la cura. Evoluzione Storico-Giuridica, Prospettive Sociologiche E Architettoniche, Giappichelli, Torino 2024.